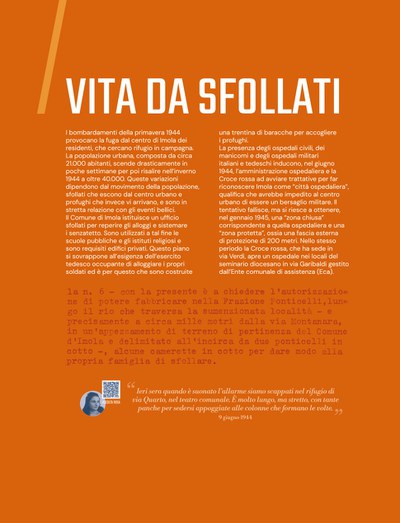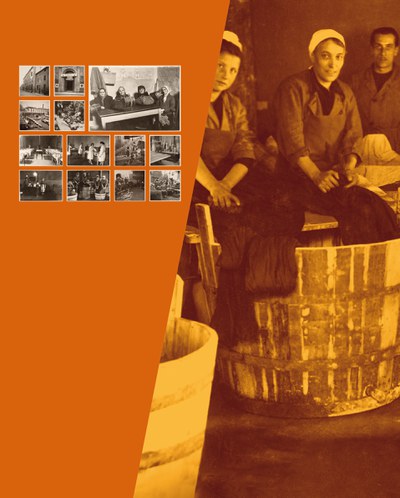Vita da sfollati
I bombardamenti della primavera 1944 provocano la fuga dal centro di Imola dei residenti, che cercano rifugio in campagna.
La popolazione urbana, composta da circa 21.000 abitanti, scende drasticamente in poche settimane per poi risalire nell’inverno 1944 a oltre 40.000. Queste variazioni dipendono dal movimento della popolazione, sfollati che escono dal centro urbano e profughi che invece vi arrivano, e sono in stretta relazione con gli eventi bellici. Nel maggio 1944 il numero di profughi in città è di 4290 e aumenta a oltre 10.000 in dicembre.
Il Comune di Imola istituisce un ufficio sfollati per reperire gli alloggi e sistemare i senzatetto. Sono utilizzati a tal fine le scuole pubbliche e gli istituti religiosi e sono requisiti edifici privati. Questo piano si si sovrappone all’esigenza dell’esercito tedesco occupante di alloggiare i propri soldati ed è per questo che sono costruite una trentina di baracche per accogliere i profughi.
La presenza degli ospedali civili, dei manicomi e degli ospedali militari italiani e tedeschi inducono nel giugno 1944 l’amministrazione ospedaliera e la Croce rossa ad avviare trattative per far riconoscere Imola come “città ospedaliera”, qualifica che avrebbe impedito al centro urbano di essere un bersaglio militare.
Il tentativo fallisce, ma si riesce ad ottenere dai tedeschi, nel gennaio 1945, una “zona chiusa” corrispondente a quella ospedaliera e una “zona protetta”, una fascia esterna di protezione di 200 metri. Nello stesso periodo la Croce rossa, che ha sede in via Verdi, apre un ospedale nei locali del seminario diocesano in via Garibaldi gestito dall’Ente comunale di assistenza (Eca).
Vai alla sezione successiva "Alessandro Bianconcini, una storia di eroismo e coraggio"
Torna a sezione precedente "Imola sotto le bombe"